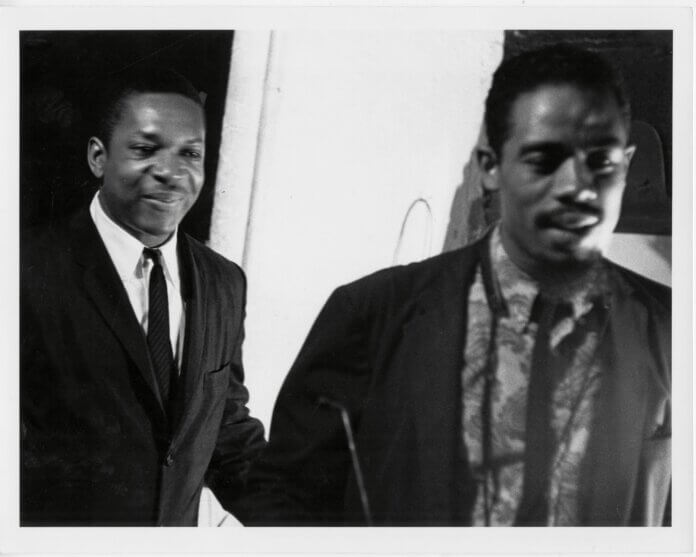BRANFORD MARSALIS
Alla morte di John Coltrane, un medico chiamato Cuthbert Simpkins sospese la sua attività professionale, saltò in macchina, raggiunse New York e si mise a intervistare musicisti e altri membri della comunità jazzistica cittadina, poi scrisse un libro su di lui. I nastri di quelle interviste sono oggi custoditi nella biblioteca della Duke University e io li ho potuti ascoltare, compreso uno in cui Ornette Coleman racconta a Simpkins della volta in cui Coltrane gli aveva detto di aver capito che, se voleva spingersi più in là, doveva smettere di suonare gli standard in quanto la sua mente era ormai bloccata su un certo modo di interpretarli. Più o meno questo vale per tutti, perché se io dovessi salire sul palco e suonare You Don’t Know What Love Is finirei per farla alla maniera di Sonny Rollins, con In a Mellow Tone mi rifarei a Ben Webster, e ovviamente con The Night Has a Thousand Eyes mi ritroverei a suonare come Coltrane.
Secondo me Ornette ha giocato una grossa parte nella direzione presa da Coltrane nel 1961. Dev’essere stato per via di quel disco, «The Avant-Garde», che Trane aveva inciso con alcuni membri del gruppo di Coleman e in cui si cimentava in uno stile più free, non lineare, completamente diverso dal modo in cui aveva suonato fino ad allora. Per quanto mi riguarda, non è che quei brani mi ricordino la musica di Ornette: sono semplicemente convinto che a Coltrane fosse bastato cimentarsi con quel sound per arrivare a una nuova consapevolezza in cui, per l’appunto, l’influenza di Coleman era decisiva. Gira la strana convinzione che, se vuoi suonare come Coltrane, non devi far altro che comprare tutti i suoi dischi, qualche volume di trascrizioni e darci dentro come un matto. Fu durante la mia permanenza nei Jazz Messengers che iniziai a gettarmi sul serio nella sua musica, ma capitò che Art Blakey mi sentisse e sbottasse con un: «In questo modo non imparerai mai come si fa». «Ah» risposi io, «stai dicendo che se voglio suonare come Coltrane devo ascoltare qualcun altro?» E lui: «Sto dicendo che quando Coltrane aveva la tua età, cosa cazzo credi che ascoltasse? Qualche nastro di musica che era ancora ben lungi dal suonare?». Giusto. Non avevo bisogno d’altro. Andai a parlare con Benny Golson, che mi chiese: «Giovanotto, ma l’hai ascoltato bene Johnny Hodges? Per me dovresti. Vedrai che comincerai a capire qualcosa di Coltrane».
Coltrane era un po’ come i Borg di Star Trek, la specie che cerca e trova il meglio delle altre culture e lo assorbe nella sua coscienza comune. Coltrane era la somma di tutte le sue esperienze precedenti, comprese le sue incursioni nel r&b, il passaggio nella band di Earl Bostic e in quella di Johnny Hodges, l’essersi ritrovato nel quintetto di Miles Davis e poi con Monk, sempre assorbendo nuove informazioni. Anche l’essere cresciuto in una congregazione pentecostale. Insomma, Coltrane poteva anche suonare in maniera parecchio astratta, ma il motivo per cui questa roba funziona è legato alle altre mille cose che aveva fatto.
Coltrane nel 1961, dite? Sono giusto andato a guardare le classifiche di Billboard di quell’annata. Tra i cento singoli più venduti c’erano Bobby Lewis, Patsy Cline, gli Highwaymen, Roy Orbison, Del Shannon, i Jive Five, Chubby Checker, gli String-a-Longs, Dee Clark, Joe Dowell e Lawrence Welk. Ecco la cosa davvero singolare di quell’epoca: artisti degli anni Trenta e Quaranta riuscivano ancora a trovare lavoro. E poi: Connie Francis, Ray Charles, Ernie K-Doe da New Orleans, i Dovells, Ricky Nelson, i Miracles. In questa classifica, Trane non l’ho trovato, e neanche Miles. Non c’è nessuno dei «nostri». Nessun riferimento al sound di Coltrane nella musica che all’epoca era considerata popolare. Ma la sua intenzione era quella di suonare la sua musica e farlo nei locali tipo il Village Gate. Chi sceglie di suonare musica barocca non è mica scemo: sa bene che per tutte la vita gli toccherà farlo nelle chiese o nelle piccole sale da concerto. Sono scelte che hanno delle ovvie conseguenze, e io ammiro chi le fa. Con Coltrane è lo stesso, e si capisce da queste registrazioni. Questa è la sua strada, lui fa ciò che ha deciso di fare, e non ci sono commenti e critiche che tengano, anche a costo di dover suonare per dieci persone.
Mi è capitato di tenere masterclass a livello universitario, per musicisti che nutrono ambizioni di successo e di scalata sociale. La faccenda è molto più complicata di come la sto spiegando, ma quando mi sento chiedere «Come si fa a ottenere un ingaggio? Come si riesce a far soldi?» e non «Come posso migliorare?» rispondo sempre che l’obiettivo è imparare a fare entrambe le cose. Coltrane era un tipo temerario, e possedeva l’incredibile capacità di tirar fuori il meglio dai collaboratori che portava sul palco. Erano tutti grandi musicisti, e facevano al meglio il loro mestiere: cambiare atmosfere e situazioni per adattarsi al solista di turno. Qui, per come la sento io, Coltrane e il suo gruppo stanno ancora cercando di sistemare le cose, capire per esempio quand’è che devono entrare i fiati e quando no. Siamo ancora nella fase dei lavori in corso, nelle incertezze tipo: «Hmm… Sì, forse, magari funziona. Anzi no, non funziona un bel niente». Non sono contrario a questa procedura, per quanto mi riguarda, anche se non con la mia band non ci mettiamo a lavorare agli arrangiamenti proprio lì, sul palco.

Questa musica segna l’inizio di un grosso cambiamento per Coltrane, che tendeva verso una nuova direzione; e, se parliamo dell’intensità che comunemente viene associata al classico quartetto Tyner-Garrison-Jones, eccone qui l’anticipazione. Trane era fresco del successo di «Giant Steps», dove aveva sperimentato un nuovo approccio ai brani, per esempio su Countdown o su 26-2 [rimasta poi fuori dall’album, NdT]. La maggior parte dei musicisti non si sarebbe più schiodata di lì per tutta la carriera. Ma Coltrane, all’incirca dopo un anno e mezzo, aveva già mollato quella procedura, convinto di averne ormai abbastanza, ed era tornato a gettarsi dritto nel pentolone. Quanti musicisti, oggi, hanno il coraggio e la fiducia in sé stessi di fare una scelta del genere, di andare contro le loro idee più recenti? I più avrebbero paura dell’ignoto, o di ricevere cattive recensioni. E invece è proprio così che il quartetto di John Coltrane è diventato uno dei più grandi small groups nella storia del jazz.
REGGIE WORKMAN
John ha trascorso molto tempo a Filadelfia, anche dopo essersi unito a Miles per poi trasferirsi a New York, e soprattutto più tardi, quando stava cominciando a formare la sua band. Vivevo lì, in quegli anni di transizione, e quando arrivava in città stavo sempre seduto sotto il palco della band. Andavo a sentire Miles e ascoltavo gli assolo di John, ogni nota che suonava. Una sera dopo l’altra, sentivo la sua voce uscire dal suo strumento, a qualunque livello lui si trovasse in quel preciso istante. Quelli erano i club del mio quartiere, e frequentavo lo stesso giro di John. Molti amici, infatti, li avevamo in comune.
Fu nel febbraio del 1961 che entrai per la prima volta nel gruppo di John. Poco dopo, lui iniziò a sperimentare con un secondo bassista. E capitò diverse volte, come a Chicago con Donald Garrett (che mi sostituì quando mi feci venire le vesciche sulla mano destra suonando così forte) e al Cork N’ Bib, e poi al Village Gate con Art Davis. Credo che l’idea di utilizzare due bassi fosse un’estensione di diverse cose, incluso ciò che stava accadendo con i musicisti di Chicago, e soprattutto l’ascolto di molta musica africana. John diceva: «Vogliamo farvi suonare, tu e Art, come un coro di tamburi», così diatonicamente accordati, allo stesso modo in cui i tamburi hanno armonici, ma non necessariamente in sintonia con i fiati. Uno di noi manteneva la pulsazione, l’altro esplorava e si integrava con ciò che stava accadendo con i fiati. Essendo un musicista classico, Art stava nella parte alta del contrabbasso suonando nella prima posizione, quella del pollice, mentre io mantenevo il groove, le fondamenta.
Durante il 1961, John stava seguendo un approccio armonico diverso. Dava più spazio agli assolo e proveniva da una prospettiva diversa nel modo in cui costruiva le sue composizioni, o come dovrei chiamarle, motivi. Il gruppo riusciva a funzionare in modo diverso all’interno di quei parametri rispetto a quello che avevamo suonato in precedenza. Per lui fu un periodo di esplorazione. Era sempre alla ricerca di nuovi suoni, e la presenza di Eric nel gruppo faceva parte di questo processo. John rispettava molto Eric, erano molto affini nelle concezioni musicali. Ascoltando le registrazioni del Village Gate, si può sentire come Eric prendeva lunghi assolo e John lo seguiva, suonando un assolo molto più breve di quanto non facesse di solito e lasciando che la voce di Eric emergesse in modo evidente. Ricordo John seduto su un lato del palco, e lo ascoltavo fare molte cose diverse. Amava il suono di Eric al clarinetto basso.
When Lights Are Low è un ottimo esempio di come John dava spazio a Eric. Era uno dei brani che venivano suonati spesso a New York. Miles l’aveva registrato e reso famoso. Ogni musicista lo suonava. Lo sentivi in tutte le jam session. Ma quando Eric si univa a noi, lo faceva con molta libertà. Lo sento in questa registrazione. Dovevamo suonare il bridge e le cose sono diventate un po’ confuse riguardo alla struttura del brano. Ma Eric era abbastanza bravo a gestire la situazione e suonava fraseggi neutri, quindi la faceva andare bene anche se noi eravamo in un punto diverso.
John apprezzava molto il Village Gate. Era un luogo confortevole in cui stare e rilassarsi. I camerini erano proprio dietro il palco dove lui faceva sempre praticacon il suo strumento. In quel periodo, il Village era un luogo esplosivo con ogni tipo di musica: il Café Wha? era proprio dietro l’angolo. I locali erano su Houston e su Thompson Street. Piccoli locali dove si cantava e si suonava solo con le chitarre, musica folk e caffè che ospitavano artisti come Bob Dylan e Buffy St. Marie. Il jazz era davvero dappertutto, allora.
Dopo il Village Gate andammo in tour, poi rientrammo a New York per suonare al Village Vanguard con molti altri musicisti aggiunti, infine ci recammo in Europa: la mia prima esperienza all’estero. Era uno show potente, con il quintetto di Dizzy e la band di John: Elvin e Mel Lewis, tutto nella stessa serata! Fu un tour molto intenso.
Quando tornammo negli Stati Uniti alla fine di dicembre, Jimmy Garrison si unì definitivamente alla band su suggerimento di Ornette Coleman. In quei giorni Jimmy stava lavorando con Ornette ed era venuto a suonare con noi al Vanguard. John capì subito come Jimmy e Elvin comunicassero bene tra loro. Avevano un bel feeling.
In quel periodo ero impegnato a badare a mia madre a Filadelfia mentre mio padre stava combattendo contro il cancro, quindi John proseguì con Jimmy. Penso che sia stata una scelta eccellente. John si stava evolvendo, anche la band stava cambiando, e lui voleva circondarsi di persone che la pensassero allo stesso modo. Così fece questa scelta, mosse un passo avanti e Jimmy ed Elvin diventarono il nucleo del gruppo: una cosa molto importante. John cresceva senza sosta, passando da una fase all’altra. All’inizio per suonare con lui aveva scelto Paul Chambers, in seguito Steve Davis. E dopo Steve prese me, cosa di cui sono molto grato. Quando lavoravamo insieme, la gente gli chiedeva di suonare pezzi che aveva sentito in una registrazione fatta due o tre anni prima, mentre la sua concezione musicale continuava ad andare avanti. Spesso gli facevo domande a riguardo. Lui diceva: «Quando la gente capirà ciò che faccio oggi, la mia mente sarà già altrove». Le sue precise parole, che ho tenuto sempre con me come una lezione. John mi fece capire di essere sempre disposto ad abbamdonare le cose che aveva fatto ieri per passare alla fase successiva. Si rese conto che era molto importante registrare la musica e pubblicarla il prima possibile, perché il pubblico potesse sentire dove lui si trovava in quel momento, così iniziò a inserire questa clausola nel suo contratto discografico.
Sono sicuro che, se fosse dipeso completamente da lui, John sarebbe stato molto più veloce nell’andare avanti. Sapeva che se il pubblico non avesse ascoltato ciò che stava facendo, gli avrebbe comunque chiesto di suonare My Favorite Things. Però era il tipo di persona sempre disposta a venire in aiuto e offrire una sorta di chiave per comprendere ciò che stava facendo – qualche melodia familiare, o qualche modalità familiare, o qualche raga familiare. Qualcosa con cui le persone potessero avere un rapporto. Così prese My Favorite Things e ci aggiunse un vamp, riuscendo a dare al pubblico sufficiente melodia per poi trasmettergli il suo messaggio nella sezione aperta del brano. Funzionò così bene che disse: «Forse lo proverò di nuovo in futuro, con altre cose». E così fece, con brani come Greensleeves, Inch Worm e Chim Chim Cheree.
Quando eravamo in tour, c’erano volte in cui avevamo stanze attigue e io lo sentivo tutta la notte, perché ero abituato a restare sveglio e a esercitarmi. John soffiava nel suo strumento, senza emettere alcun suono ma muovendo solo le chiavi. C’erano volte in cui bussavo alla sua porta, e lui era lì che leggeva libri mentre studiava: libri di filosofia, sugli aspetti universali della vita e quelli spirituali dell’esistenza.

Spesso John mi diceva: «Dammi retta, non smettere mai di crescere. Non smettere mai di muoverti. Non smettere mai di creare». John era un uomo taciturno, quindi ogni sua parola aveva un gran peso. Per capirlo, dovevi prestare attenzione a come viveva, a cosa creava. E ancora oggi lo puoi sentire nella sua musica. Puoi capirlo dai titoli che dava alle sue composizioni, che è un tipo cui è necessario prestare attenzione. Allora, se sei pronto, potrai ricevere il messaggio, come ci insegna la filosofia induista. Altrimenti devi tornare al punto di partenza, prepararti bene e provare un’altra volta. Capito?
RICHARD ALDERSON
Divenni un appassionato di jazz dopo aver scoperto questa musica sui dischi di Charlie Parker. Quella che John Coltrane suonava nel 1961 non mi colpì allo stesso modo, non fu altrettanto sorprendente. Alle mie orecchie i progressi di John suonavano come la naturale conseguenza di ciò che faceva sin dai tempi con Miles. Fu allora che lo ascoltai per la prima volta dal vivo e imparai a familiarizzarmi col suo suono sia al Village Vanguard sia in altri club. John era all’avanguardia nel mondo del jazz, proprio come mostrano queste incisioni del Village Gate. Aveva appena iniziato a ottenere un grande successo commerciale con «My Favorite Things». Quell’estate fu entusiasmante avere Coltrane al Gate perché la situazione sembrava così nuova e diversa, come se qualcosa stesse per accadere.
Ho fatto il tecnico del suono e il produttore per tutta la vita. Ho iniziato fin da piccolo, a Cleveland. All’inizio amavo ogni genere di musica classica, compresi Schoenberg e Webern. La mia carriera è nata dal fatto che ero un appassionato di hi-fi. Costruii il mio primo impianto a 15 anni, ma ho sempre voluto essere un tecnico del suono. A 18 anni mi recai a New York per la prima volta. Poco dopo mi sposai e ci trasferimmo al Village, andando ad abitare al 148 di Bleecker Street, tra Thompson Street e West Broadway, un luogo poi ribattezzato La Guardia Place.
La mia carriera ebbe inizio al Village Gate di Art D’Lugoff intorno alla primavera del 1961, quando avevo 22 anni. Il club era stato aperto qualche anno prima ed era giusto a mezzo isolato di distanza da casa mia, in Bleecker Street tra la Sullivan e la Thompson. Allora l’ingresso era su Thompson Street. Fui assunto per installare e gestire l’impianto audio del club. Quello che avevano allora era una sorta di impianto voce, un’autentica barzelletta. Ma all’epoca la maggior parte dei club non aveva nemmeno un impianto. Così portai tre casse KLH, un amplificatore e un mixer Altec: nessun diffusore sul palco. Era molto complesso, per l’epoca. Un anno dopo, installai una versione più piccola dello stesso setup per il folk club Gaslight, sulla MacDougal. Art mi ha sempre promosso e sostenuto, e continuò a raccomandarmi anche quando me ne fui andato, aiutandomi a trovare lavoro.
Fu Chip Monck a presentarmi Art per la prima volta. Chip era il responsabile delle luci del Village Gate: aveva iniziato come custode, si era fatto strada arrivando a installare un sistema di illuminazione professionale, e fu proprio lui a consigliare me per occuparmi dell’impianto audio. Avevamo un buon rapporto e lavoravamo insieme agli spettacoli. La gente era stupita: non aveva mai visto luci e suono lavorare in sincronia in quel modo. In seguito Chip passò a progettare palchi e luci per il Monterey Pop Festival, Woodstock e infine per i Rolling Stones. All’epoca lui viveva in una stanza dietro la sala principale del club e in quel momento io dovevo essere tra una moglie e l’altra, perché ricordo di aver dormito lì un mese, quell’estate. Bob Dylan capitava spesso al Gate e fu proprio lì che scrisse A Hard Rain’s a-Gonna Fall.

Il Village era in pieno fermento, in quel periodo: bar e night club con spettacoli comici, teatro sperimentale, letture di poesie e musica dal vivo. Anche nei ristoranti: folk, Broadway, jazz. Tutta la scena stava diventando popolare. Ricordo un gran pubblico al Gaslight e al Café Wha?, e dopo un po’ anche al Village Gate.
Nel 1961 il Village Gate era uno dei locali di jazz più ampi e qualitativamente migliori di New York. All’epoca era costituito da un solo ambiente. La sala al piano superiore e gli altri spazi vennero dopo. Quasi tutti gli altri club, come il Village Vanguard e il Five Spot, erano piccoli. Il Gate aveva tavoli per qualche centinaio di persone e serviva cibo di qualità. E nel 1961 iniziava a ospitare alcuni dei migliori musicisti di jazz sulla piazza, come Nina Simone, John Coltrane, Art Blakey, Horace Silver e Herbie Mann. D’Lugoff era famoso per la sua programmazione eclettica: era capace di mettere cabarettisti e jazzisti nella stessa serata, o cantanti di folk ed esponenti di Broadway. A volte funzionava, a volte no.
Fu proprio allora che alcune case discografiche iniziarono a incidere al Gate. La Colpix mi chiese di fare una registrazione dal vivo e pagò anche il club. Quella che sul disco si sente dire: «E adesso il Village Gate ha il piacere di presentare Miss Nina Simone» è la mia voce. Una voce che è ancora molto simile ad allora. Un anno dopo registrai Bob Dylan al Gaslight e, di nuovo al Gate, altri musicisti di jazz come Thelonious Monk. I nastri di Coltrane e del suo gruppo non vengono da un mio progetto segreto di registrazione, e neanche D’Lugoff sapeva che lo avrei fatto. Volevo essenzialmente sapere come suonava l’impianto nella sala. Volevo anche provare un nuovo microfono a nastro che mi aveva passato Bob Fine, del Fine Recording Studio. Bob era uno dei miei mentori. Il microfono era un vecchio RCA 77-A che avevo modificato rimuovendone la parte posteriore per renderlo più omnidirezionale ed eliminare l’effetto «scatola».
Questa di Coltrane è stata l’unica volta che ho usato un solo microfono per una performance dal vivo. Se la registrazione era destinata alla messa in commercio, usavo un setup più completo. Nel 1982, con Grover Washington Jr., avevo uno studio mobile completo e più attrezzature di quante ne possiate immaginare. Al Gate, il punto ideale per il microfono era nel soffitto sopra il palco, quindi sistemai lì l’RCA, feci passare il cavo lungo tutto il club fin nella stanza di Chip e registrai la musica su un Nagra III a bobine. Ricordo che per controllare il suono usai un paio di cuffie della Beyer.
In questa registrazione, anche senza mixaggio, si sentono molto bene Coltrane e la batteria, così come il pianoforte, il basso e Dolphy. C’è anche una bella acustica ambientale, pubblico e applausi compresi. È come se oggi questa registrazione mi mettesse davanti agli occhi quella sala al piano interrato e tutta la potenza di quel gruppo, specialmente Elvin Jones. Non ho mai conosciuto un batterista jazz più grande di lui, nessun dubbio. Il modo in cui suonava era perfetto per Coltrane: Elvin eccelleva in quel ruolo. Diventammo amici ed elaborammo un progetto per realizzare un film assieme a un fotografo che conoscevo. Doveva intitolarsi Pigeons on the Grass, Alas, come la poesia di Gertrude Stein, e sarebbe stato girato a Bryant Park. Elvin avrebbe dovuto scrivere la colonna sonora. Abbiamo fatto uno storyboard con un sacco di piccioni, ma è finita lì.

Dai club del Village passai a lavorare con Harry Belafonte e poi aprii il mio studio di registrazione sulla 65th Street, vicino a Broadway, che inizialmente battezzai RLA Sound – le mie iniziali – e in seguito Impact Sound, su suggerimento di Harry che divenne il mio socio. Nel corso degli anni all’Impact registrai la maggior parte degli album della ESP Records e feci sedute per tante altre etichette come Prestige, Fania e così via. Nel 1965 e 1966 fui ingaggiato per allestire l’impianto audio di palco per Bob Dylan e partii in tour con lui. Intorno a quel periodo, venni anche coinvolto dall’Institute of Sound presso la Carnegie Hall, una piccola organizzazione no profit gestita da un ex attore bambino di nome Richard Stryker che si occupava di salvaguardare registrazioni storiche, soprattutto di opere liriche.
Alla fine, quando Nixon fu eletto nel 1968, decisi di emigrare e lasciai tutte le mie bobine – incisioni di diversi musicisti, i miei stessi lavori di musique concrète – all’Istituto. Sei anni dopo, al mio ritorno, scoprii che Richard Stryker era morto e che tutte le registrazioni erano state donate alla New York Public Library. Non ne seppi più nulla per molto tempo, ignoravo che fossero ancora lì fino a quando Parker Fishel, cacciatore di materiali d’archivio di Dylan, trovò una scatola che recava la scritta «Alderson?», con il punto interrogativo. Fishel stava cercando soltanto le registrazioni del Gaslight. Il resto è stato catalogato dalla biblioteca, inclusi i nastri di Coltrane. Fu un sollievo sapere che la scatola era stata finalmente trovata, ma c’è una registrazione che è ancora perduta e sarei molto contento di veder riapparire: un pezzo di musique concrète che ho creato tagliando e montando In a Mist di Bix Beiderbecke. Ne ero parecchio orgoglioso.
Sono lieto che queste registrazioni siano state recuperate e felice di averle registrate. In un certo senso vorrei averne fatte di più, ma non è andata così. Ero giovane, lavoravo come tecnico del suono a contratto e, quando chiedevano il mio apporto, cercavo di fare del mio meglio. Quell’estate, Coltrane suonava in maniera incredibile e apprezzai anche cosa seppe fare in seguito della sua musica, quando divenne ancor più all’avanguardia e portò il jazz un passo ben più in là. Non si trasformò mai nell’artista pop che certi pensavano potesse diventare. Prese tutta la notorietà ottenuta con «My Favorite Things» e la sviluppò in qualcosa di ancora più valido.
(traduzioni di Luca Conti)
KEN DRUKER
parla con Nicola Gaeta
I miei amici di Universal Italia mi hanno detto: «Stai per intervistare un vero e proprio Indiana Jones della discografia». Apprezzo molto il lavoro che stai facendo nel riscoprire tesori nascosti come questo «Evenings At The Village Gate», la cui pubblicazione hai prodotto, e mi piacerebbe che tu raccontassi in prima persona com’è andata.
In linea di massima ti rimando a quel che ha scritto Richard Alderson, il tecnico del suono: so che avete tradotto il suo testo per la vostra rivista. Aggiungo, per completare il tutto, che i responsabili della New York Public Library, una volta appreso del ritrovamento dei nastri, chiamarono Lewis Porter, il grande esperto di Coltrane che immagino tu conosca. Fu lui ad aiutarli a identificare il contenuto, e fu sempre lui a telefonarmi pensando che potessimo essere interessati alla pubblicazione. Certo che lo eravamo! Su quei nastri c’erano i primi quattro brani che adesso sono sul disco, My Favorite Things, When Lights Are Low, Impressions e Greensleeves. Pochi anni dopo il batterista George Schuller, figlio di Gunter Schuller, mentre stava facendo delle ricerche su Lee Konitz, sempre alla NY Public Library, scoprì un altro nastro che conteneva il brano Africa e che apparteneva alla stessa esibizione al Village Gate, ma con una piccola differenza: l’aggiunta di Art Davis al contrabbasso – in quel brano suonano due contrabbassisti – che ovviamente abbiamo inserito nell’album.

1961. Lo stile di Coltrane è sempre stato in continuo movimento, ma quello fu un periodo in cui la sua versatilità produsse alcuni dei frutti migliori della sua discografia. C’era la musica di «Evenings At The Village Gate» ma due anni dopo il sassofonista incise «Ballads» e il disco con Johnny Hartman. La sua musica è sempre stata piena di piacevoli sorprese. Qual è il motivo principale per cui un fan di John Coltrane dovrebbe procurarsi questo disco?
Ci sono almeno un paio di motivi. Come ben sai, c’è molto di John Coltrane in giro ma non altrettanto di Eric Dolphy, e la loro era una combinazione esplosiva. Musicalmente erano una coppia perfetta. Visto che hai già ascoltato: «Evenings At The Village Gate», riesci a pensare a un altro momento in cui un membro della band di Coltrane abbia avuto una vetrina così importante come Dolphy in When Lights Are Low? Nessuno dei membri stabili del suo gruppo ha mai avuto una simile vetrina, per quel che mi ricordo, e poter ascoltare John ed Eric suonare insieme in quel momento storico lo vedo come un dono davvero speciale. La seconda cosa interessante, alla quale non avevo pensato, mi è stata suggerita da George Schuller: in quel periodo era stato appena pubblicato «My Favorite Things», credo nel marzo 1961, ed era stato un grande successo, quasi un successo pop, e molti credettero che John Coltrane stesse per diventare una pop star. Ovviamente non era ciò che John Coltrane aveva in mente di diventare, per cui tutte queste persone rimasero sorprese e scioccate quando capirono che lui non stava capitalizzando quel successo ma, al contrario, «si limitava» a inseguire la sua visione musicale che oggi sappiamo avrebbe caratterizzato la sua successiva produzione musicale per il resto della sua vita. All’epoca quel successo commerciale depistò molti addetti ai lavori, giornalisti ma soprattutto proprietari di club che speravano di aver una grande pop star sui loro palchi. Credo che fosse molto importante testimoniare tutto questo.
In quest’ultimo periodo molte etichette discografiche stanno lavorando attorno alla riscoperta di materiale mai pubblicato di alcuni artisti che hanno segnato un capitolo importante nella storia del jazz. Sto pensando non solo a Coltrane ma anche a gente come Lee Morgan, Monk, Elvin Jones, Art Blakey eccetera. Ma, a parte le esigenze del marketing, quale pensi sia la ragione per cui questo materiale non sia stato pubblicato all’epoca?
Credo che cambi da una circostanza all’altra. Quando Zev Feldman, per esempio, ha scoperto la musica di «Live in Seattle» era materiale che già si sapeva provenire dai concerti fatti al Penthouse. Nel nostro caso noi ignoravamo completamente l’esistenza di questi nastri nella NY Public Library, e, come dicevi tu, a parte le esigenze del mercato, ritengo che sia una questione legata al periodo in cui queste cose vengono scoperte.
Sappiamo che ci sono tante registrazioni che non sono mai state pubblicate: ci sono tanti bootleg che abbiamo scelto noi di non far uscire, e nel caso di Coltrane la famiglia pensa che ci siano troppe registrazioni che non sono molto diverse dalla musica già pubblicata e che nulla aggiungono a ciò che conosciamo già. Sono sicuro che anche tu avrai ascoltato molte registrazioni live che sono sì molto buone ma troppo simili a qualcosa che già esiste. Per cui dobbiamo essere molto esigenti quando decidiamo di scegliere qualcosa da immettere sul mercato, dobbiamo assicurarci che ci sia una storia dietro, fare in modo che la gente lo possa scoprire e trovare interessante e che questo materiale non tolga niente, in nessuna maniera, all’eredità musicale lasciata dagli artisti di cui ci stiamo occupando. È una scelta difficile: non hai idea di quanta gente ci sottoponga cose che non meritano di essere pubblicate.
John Coltrane è stato uno dei geni del secolo scorso. Se ti chiedo di sintetizzare la sua grandezza in pochi punti, tu che mi rispondi?
Parlerei soprattutto della sua inarrestabile ricerca. Se pensiamo al periodo di tempo in cui si è svolta la sua carriera, «My Favorite Things» esce nel marzo del 1961 e John Coltrane muore nel luglio del 1967. Solo sei anni! Guarda il divario stilistico della musica fatta da Coltrane in questi sei anni, da album ad album, e non considerare la data di uscita dei dischi perché sono stati pubblicati in momenti diversi; ma se prendi in considerazione tutto ciò che ha registrato nel corso di questi sei anni ti rendi conto che è accaduto qualcosa di sconvolgente. Coltrane era sempre pronto a passare alla scoperta successiva: nella sua testa si agitavano così tante idee che gli veniva fuori sempre qualcosa di diverso. Era influenzato da mille situazioni. Sì, confermo, quel tipo di ricerca così inarrestabile non veniva assolutamente influenzata da alcun tipo di esigenza che non fosse quella artistica e interiore. Ovviamente il suo pubblico lo seguiva, ma lui andava avanti (e sarebbe comunque andato avanti) lo stesso, a costo di deludere quella parte di ascoltatori che lo avevano seguito fino a «My Favorite Things» e che da allora in poi non riusciranno più a stargli dietro. Questo mi sembra l’aspetto più importante della sua grandezza. E poi l’incredibile ampiezza stilistica di ciò che poteva fare. Quando ascolti le sue bellissime ballad – prima hai citato l’album con Johnny Hartman – e sai che contemporaneamente, anzi due anni prima, lui registrava questo tipo di cose, ti rendi conto che è tutto autentico. John non stava andando a ritroso per suonare un vecchio standard, tutto era dentro di lui, all’interno della sua ricerca interiore. E questa padronanza di tutta la musica gli permetteva di andare da Johnny Hodges fino all’infinito, per poi diventare un punto di riferimento per tutte le generazioni di musicisti che sono venuti dopo di lui. È scioccante ciò che è riuscito a fare dal 1959 al 1967, in otto anni da leader. Non so tu, ma io non ho mica fatto tanto di così interessante negli ultimi otto anni! Lui in otto anni ha fatto tutto questo. Ed è, a mio avviso, una cosa straordinaria e che ti lascia senza parole.
È vero. La sua musica, e specialmente la musica di quegli anni, ha marcato una traccia importante di tutta la musica del ventesimo secolo. Era energica e, nello stesso tempo, spirituale. Oggi si assiste a un ritorno di attenzione per quel tipo di sonorità che alcuni definiscono «Spiritual jazz». Ma, a parte le etichette, cosa secondo te, rende la sua musica così influente ancora oggi?
Credo che sia principalmente perché la sua musica è sincera, viene dal cuore, non è stata creata per fini biecamente commerciali e possiede un profondo senso spirituale oltre che una profonda conoscenza della storia. Incorpora tutti questi elementi in qualcosa di unico. Se tu pensi invece a quanto fosse commerciale gran parte della musica pop di quel periodo, capisci subito che la musica di Coltrane si poneva come un’alternativa, si collegava a qualcosa di più profondo che gli veniva dall’anima. Ritengo che la sua musica contenga qualcosa di tanto viscerale da essere attuale ancora oggi, anzi oggi ancora di più. Musicisti come Pharoah Sanders o Archie Shepp hanno anche loro avuto una forte influenza, ma nessuno ha superato John in termini di profondità. Tutto parte da Coltrane, e se oggi uno Shabaka Hutchings, per esempio, può fare quel che fa, lo deve a lui. Tutto sgorga da quella fonte ed è una fonte molto generosa, dalla quale ognuno può prendere la propria direzione perché non riguarda uno stile in particolare o un particolare strumento, è un feeling e un intenzione. Ritengo che proprio per questo l’influsso di Coltrane sia durato così a lungo e continui ciclicamente a riaffermare la sua importanza.
Io ascolto un sacco di bella musica, ogni giorno. Però hai ragione tu, la profondità del modo di suonare di Coltrane è molto difficile da trovare ancora oggi, se non largamente impossibile. Secondo te, considerando ciò che è diventato il mercato della musica, oggi Coltrane riuscirebbe ad attirare la stessa attenzione dei media e del pubblico così come ha fatto in quegli anni?
È una bella domanda, John Coltrane ai tempi di TikTok… [sorride]. Non lo so, tendo a pensare di no, ma chi lo può dire? Lui aveva un legame diretto con il suo pubblico, faceva tanti concerti, ma oggi il mercato richiede una fan base e la capacità di comunicare con i fan, soprattutto nel pop ma credo anche nel jazz. Oggi questo è considerato un aspetto necessario del marketing legato alla musica. Da quel che sappiamo, Coltrane era un personaggio schivo, abbastanza riluttante a parlare in pubblico e a rilasciare interviste. Lasciava che la musica parlasse da sé e riteneva che con la sua sola forza avesse la capacità di attrarre il pubblico. Quello di oggi, per la musica, è un mercato completamente diverso.
Qual è il prossimo tesoro nascosto?
Nel 2026 cadrà il centenario della nascita di Coltrane e abbiamo cose molto speciali già pianificate per allora.