Buongiorno Federico, parliamo subito del tuo primo album da pochissimo pubblicato con la Hora Records. E, prima di parlare del tuo gruppo, vorrei che tu ci spiegassi il concept di questo disco.
Buongiorno Alceste, il concept in realtà nasce proprio in relazione al gruppo piuttosto che al disco in sé, che è infatti servito come primo punto di approdo di un percorso piuttosto che fungere da obiettivo vero e proprio. Il gruppo nasce infatti con l’idea di esplorare varie possibilità improvvisative ed il modo in cui la composizione possa influenzarle. Riguardo al nome, Il termine “formale” indica conformità a forme prestabilite e requisiti, mentre il suo opposto si riferisce a qualcosa di non cerimonioso e spontaneo. InFormal Setting è uno spazio dove questi aspetti coesistono in musica. Lo immagino come una sorta di quadro dove le parti scritte costituiscono una cornice che rimane però aperta, incompleta, al cui interno manca il dipinto. Quest’ultimo appare e scompare, e non è mai un solo dipinto su tela, ma un insieme di immagini che cambiano continuamente e che attraversano la cornice in ogni direzione.
Invece, il tuo gruppo si è formato sui “banchi” della University di Siena Jazz, giusto?
Sì, quando ero ancora studente al triennio di Siena jazz. Da allora è cambiato molto sia per il suono d’insieme che per il repertorio, alcuni dei pezzi che suonavamo sono stati abbandonati (fortunatamente, col senno di poi) ma l’intenzione è rimasta la stessa ed ho sempre visto il gruppo come qualcosa che valeva assolutamente la pena di portare avanti ed approfondire.

Molto bella anche la copertina dell’album, realizzata da Arianna Iodice e Leonardo Guidi; copertina che sembra la perfetta sintesi della tua musica: colori e forme in libertà, pronti a riunirsi quando l’occhio ci riesce. Anche a tuo avviso questa copertina rispecchia la tua musica?
Sì, assolutamente. Leonardo e Arianna sono due visionari, nonché due persone di una gentilezza sconfinata e professionalità impeccabile. Abbiamo lavorato per due mesi a stretto contatto, io ho dato loro spunti e tematiche di partenza intorno alle quali elaborare sia le grafiche per il disco che per il video di Remains Of Human Connections, dopodiché quello che vedi è il frutto del loro lavoro. Le persone giuste al momento giusto, hanno reso visivamente quello che avevo in testa meglio di quanto potessi immaginare.
Alcune dizioni, accenti, armonizzazioni sembrano parecchie vicine alla musica classica contemporanea limitrofa all’avant-garde. C’è qualche rapporto tra te e questo emisfero musicale?
Sì, c’è indubbiamente una vicinanza nei confronti di quel mondo lì, anzi direi abbastanza esplicita visto che And I Sound Like This fa riferimento alla musica di Morton Feldman. Ma più che alla classica contemporanea mi sento in un certo senso più vicino a musicisti come quelli dell’AACM ed ai loro “discendenti” odierni. Mi rifaccio ad un certo modo di intendere improvvisazione e composizione come il risultato dell’elaborazione personale di elementi appartenenti a tradizioni e linguaggi musicali differenti. Tuttavia proprio per questo non c’è nulla di avanguardistico in quello che faccio, nel mio piccolo cerco di offrire la mia versione di un modo di fare musica che grandi Maestri hanno fatto e fanno da una vita.
C’è qualcosa o qualcuno che ha ispirato queste tue composizioni?
Musicalmente Craig Taborn, Kris Davis, Geri Allen, Henry Threadgill, Roscoe Mitchell, Tim Berne, Ches Smith, Morton Feldman, Vijay Iyer, Chris Speed, Ligeti e altri. Ma ogni composizione è ispirata a qualcosa di accaduto o immaginato a partire dalla vita di tutti i giorni, anzi sono nati prima i titoli e poi la musica. Inappropriate Behavior In A Formal Setting è una fantasia su possibili (speriamo di no) comportamenti inappropriati in certi ambienti: diciamo che nella tua testa quando ti capita di trovarti in una situazione formale, dove le persone si comportano impeccabilmente e sono tutti apparentemente gentili, ti immagini la situazione rovesciata, in cui ognuno inizia a tirare fuori il peggio di sé per le proprie frustrazioni, ansie, paure, contraddizioni riversando tutto fuori in maniera incontrollata anziché nascondere il tutto in un atteggiamento superficialmente corretto ed adeguato alle convenzioni.
Winter Light Memories è ispirata alla particolare filigrana che i raggi del sole a volte intessono d’inverno al tramonto, la luce sembra portarti immagini del tuo passato. Detta così sembra molto nostalgica ma non c’è alcuna intenzione di rendere espressamente questo sentimento.
Remains Of Human Connections è una dedica all’insicurezza umana ed alla fragilità delle comunicazioni tra persone: ogni volta che parliamo, quanto di ciò che pensiamo e sentiamo viene realmente espresso? Quanto di non detto o non compreso rimane nascosto nella mente di due persone che interagiscono attraverso la parola o anche soltanto con sguardi o gesti? Tutto ciò deve avere una forma, creare qualcosa. Una nube, o un groviglio di cavi elettrici. Nel video del brano questa cosa è resa magistralmente da Arianna e Leonardo.
No May Turkey Supper, Maybe June deriva da qualcosa di più concreto. Durante l’ultimo mio semestre al New England Conservatory of Boston, da gennaio a maggio 2020, ha fatto la sua comparsa il covid ed io per sfuggirgli me ne sono scappato a South Berwick, Maine, ospitato da amici di famiglia in una casa di campagna nel mezzo del niente. Davanti alla loro casa dall’altro lato della strada c’era una chiesa con un cartello esposto fuori con scritto No May Turkey Supper, Maybe June, che significa niente zuppa di tacchino a maggio, forse a giugno. L’ho intesa come “niente di buono oggi, vediamo domani”.
And I Sound Like This è invece il secondo frammento della frase introduttiva del personaggio di Twin Peaks The Man From Another Place, i fan della serie capiranno. Mi sono immaginato una possibile colonna sonora scritta da Morton Feldman per un cortometraggio di David Lynch.
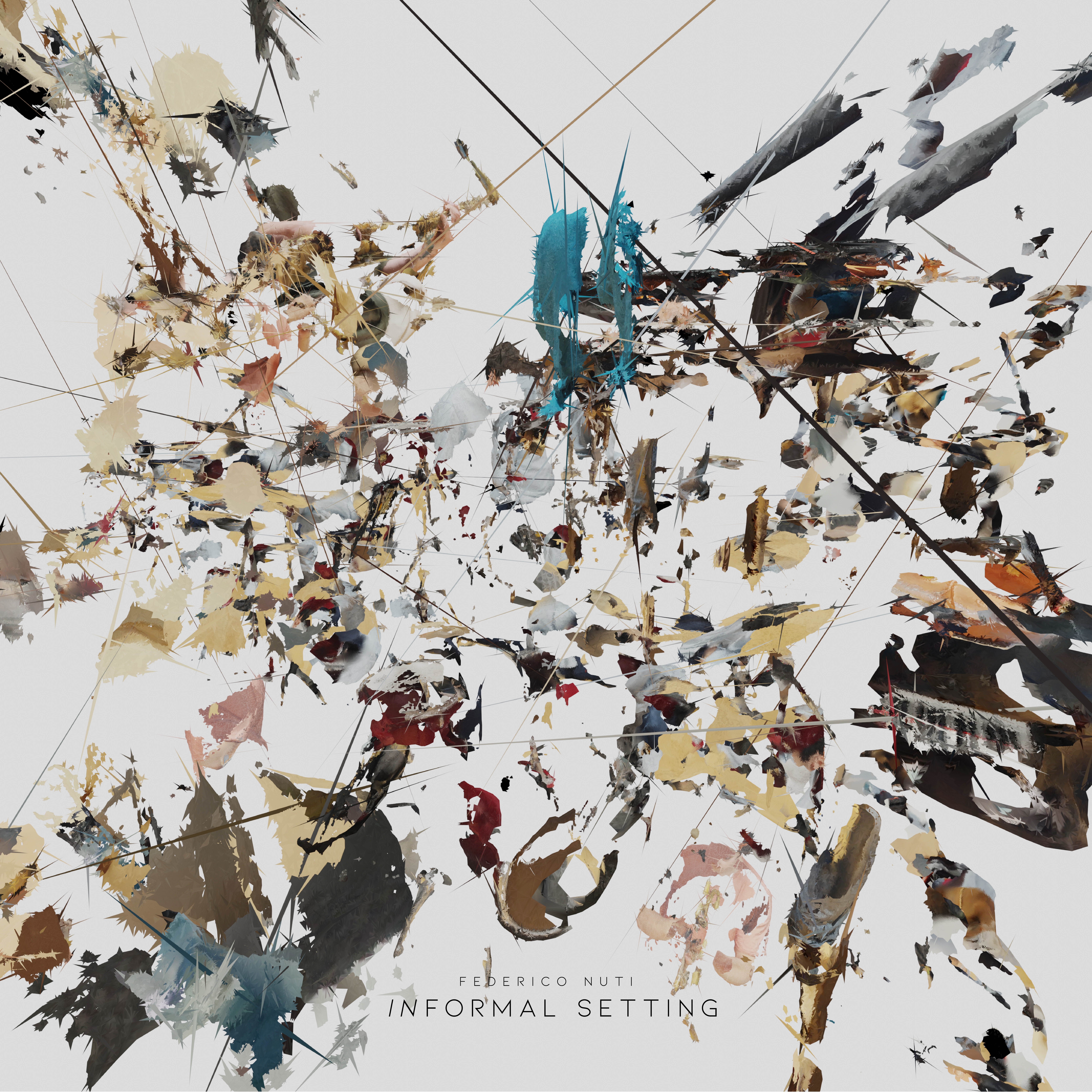
Cinque brani. E potremmo dire cinque suite, fatta eccezione per la più breve Winter Light Memories. Sei partito con questa idea di struttura oppure è maturata nel corso della fase compositiva?
No, assolutamente, la forma suite è emersa strada facendo come naturale sviluppo dell’idea iniziale di ogni brano. Ho pensato a come organizzare le idee all’interno delle composizioni e a come queste influenzavano la narrazione e di conseguenza a quali erano i punti in cui si poteva lasciare più o meno spazio all’improvvisazione. Oltre a Winter metto come eccezione anche No May, che vedo più come una sorta di giustapposizione di due macro-sezioni.
Quanto c’è di musica scritta e quanto di improvvisazione?
C’è tanto di entrambi ed è così che me l’ero immaginato. Non volevo che ci fosse troppa roba scritta che relegasse l’improvvisazione in un angolo o che la rendesse avulsa dal discorso musicale generale, né d’altro canto cercavo un espediente per improvvisare. Non che avere tanto o poco materiale scritto sia un approccio migliore dell’altro, semplicemente ero e sono interessato ad uno che tenga conto di scrittura ed improvvisazione in maniera equilibrata.
Federico, qual è il tuo background culturale e artistico?
Il primo ad influenzarmi in Italia è stato Simone Graziano, che mi ha introdotto al pensiero riguardante la forma musicale ed il processo compositivo, poi parallelamente Stefano Battaglia, che mi ha aperto occhi ed orecchie alle possibilità dell’improvvisazione, ed Alfonso Santimone per l’onnivorismo musicale, l’energia e la presenza a dir poco vulcanica in qualsiasi contesto performativo.
Se invece guardo al mio periodo negli Stati Uniti trovo Jason Moran, Ethan Iverson e Ran Blake che da allora sono rimasti miei punti di riferimento per la visione e l’approccio alla musica e al pianoforte, nonché per il modo di incorporare linguaggi musicali ed influenze diverse per creare un proprio stile.
Tu svolgi anche attività didattica proprio con l’istituzione Siena Jazz. Il numero dei giovani che si avvicinano allo studio del jazz è aumentato o diminuito nel corso degli anni?
Devo dire che fortunatamente dopo il Covid è aumentato assai, probabilmente le persone hanno voglia di vivere.
Di certo, però, è che gli studenti non frequentano molto i concerti jazz. I giovani sono sempre merce rarissima. Non pensi?
Purtroppo sì, magari questo numero si alza un po’ tra gli studenti universitari. Sfortunatamente è una lotta un po’ impari perché generalmente le persone hanno un’idea del jazz come la musichetta da sottofondo per l’aperitivo sopra la quale conversare oppure come qualcosa di troppo complesso che per essere apprezzato ha bisogno di essere prima spiegato da qualcuno “che ne capisce”. Il problema secondo me sta nei modelli che la società propone e nell’educazione all’ascolto. Ti faccio un esempio extramusicale, se io sono abituato a guardare solo film di Stallone e Schwarzenegger (per carità, nulla in contrario, sono un’amante del trash e li ho visti tutti) e un bel giorno un amico mi propone un film di Pasolini probabilmente dopo dieci minuti che lo guardo sto pensando al prossimo possibile avversario di Rocky, e dopo mezz’ora sono già andato a dormire. Magari sarei riuscito ad apprezzarlo se un altro amico prima mi avesse proposto qualcosa di simile a ciò che già conosco, in modo da incuriosirmi anche se la novità richiede un livello di attenzione leggermente superiore a Terminator XIV. Così anziché impararmi a memoria l’intera serie di Terminator avrei potuto guardarmi il primo Alien, Matrix, Blade Runner, qualcosa di Spielberg, acquisendo gusto nello scoprire cose che si avvicinano a ciò che già mi è familiare ma che man mano richiedono quel poco di dedizione in più per goderne, per poi ritrovarmi incuriosito da ciò che non conosco e dal piacere della scoperta. Certo è un processo che richiede tempo e le persone che non hanno la fortuna di essere istintivamente attratte alla musica come noi musicisti necessitano di qualcuno che le aiuti o faciliti loro il compito, che a mio parere ricade in parte sull’artista (In questo Lynch secondo me ha fatto qualcosa di unico con Twin Peaks, mescolando il suo modo visionario di fare cinema e le idee a lui care con il formato della serie TV, che nasce per il grande pubblico) ma soprattutto sulle istituzioni della società in cui viviamo. Credo che la gente si possa appassionare, devi metterla in condizione di poterlo fare, o quantomeno scegliere se farlo. Il che apre un discorso sul valore dato alla cultura in Italia decisamente troppo ampio per poterne parlare qui.

Cosa ne pensi dell’utilizzo dell’elettronica, delle tecnologie applicate al jazz?
Penso che sia un mondo ricchissimo e assolutamente da esplorare, anche se al momento non è in programma per me, almeno nell’immediato. Questo disco è il primo disco di una serie, c’è un’idea da approfondire riguardo al suono acustico ma non escludo che qualche suono elettronico possa entrare a farne parte più avanti.
Cosa è scritto nell’agenda di Federico Nuti?
C’è scritto guarisci (lunga storia), suona, studia, approfondisci, scrivi musica, preparati per i concerti, trovane altri, promuovi il progetto in cui credi, organizza le prove, iscriviti a concorsi, va’ a sentire concerti di amici e musicisti che ti circondano e ascolta i loro album, ascolta artisti che non conosci, sbriga le faccende burocratiche, organizza il prossimo house concert, passa l’esame dei 24CFU, fai sport, comprati dei nuovi mobili per la casa, organizza la festa dei tuoi 30 anni a dicembre.
Alceste Ayroldi
