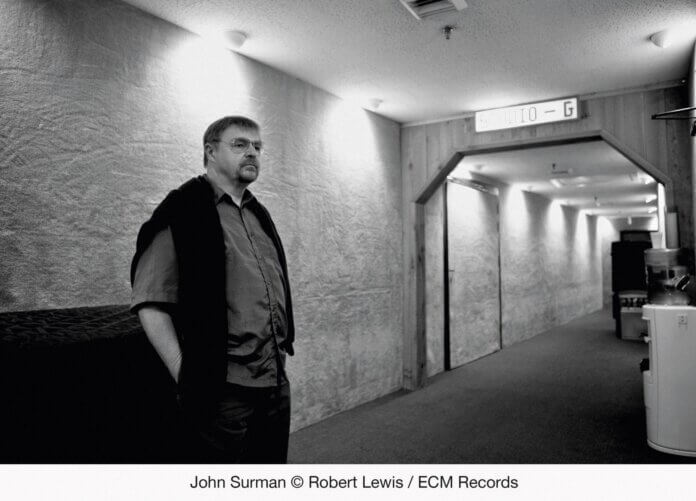Nel sottoscala dei destini si inciampa spesso in volti, luoghi e nomi sconosciuti, con ruoli più ortogonali del previsto. Al numero 24 di Market Avenue a Plymouth, per esempio, con alle spalle un fast food e uno scarico di bestiame per i banchi dei macellai, oggi si accede al Te Tao Medical Center del dottor Tony Tang, agopuntore con una laurea presa a Newcastle nel 1988; lo stesso anno John Surman, che in quella città della contea di Devon elegge i natali, era già un’affermatissima certezza dell’universo ECM e pubblicava «Private City», sua quinta uscita per l’etichetta di Monaco. Prima del Te Tao, però, al 24 di Market Avenue l’insegna era nota a qualunque appassionato di musica di Plymouth: PRHR, il Pete Russell’s Hot Records. Pete, emigrato australiano e con una infanzia un po’ da Dickens che sarebbe bello raccontare di più, dopo gli studi da perito elettronico, a corto di soldi, iniziò a metter su una piccola bottega di vinili. Entrare nel negozio (Potato Head Blues di Satchmo accoglieva spesso il cliente) di Pete era l’unica possibilità di ascoltare ogni ben di dio d’importazione dagli Stati Uniti, i nomi principali del jazz tradizionale e d’avanguardia passavano di lì. John Surman, nei Sessanta d’oro del PRHR, è un ragazzino già pieno di musica: la studia privatamente, la suona in chiesa, quando può accende la radio, la musica classica è quella che gira per casa. Ma poi, cosa sarà mai un giorno di scuola perso? Appena può entra da Pete Russell, a quel punto dotatosi di un super hi-fi per i clienti, trascorre ore ed ore ad ascoltare tutti quei suoni e quelle improvvisazioni di bellezza paralizzante. È nel carattere dell’esercente emigrato condividere vinili con i clienti più appassionati; di John deve avere una stima smodata, svelando intuito e lungimiranza. «Sai che ho comprato un sax baritono?», gli dice un giorno Surman. «Aspettami qua» e torna con le registrazioni di Harry Carney nell’Orchestra di Ellington: «ascoltati questo». Se il racconto s’è un po’ allungato è perché l’Hot Records di Pete Russell è la bottega d’artigianato all’ascolto nella quale s’è formato un protagonista assoluto della musica contemporanea, ibridatore di linguaggi, pioniere dell’elettronica ben temperata nel linguaggio jazzistico europeo, finito con l’essere conteso da tutti i nomi maiuscoli che era stato fin lì abituato ad ascoltare nel bugigattolo di 24 Market Avenue.
Con un necessitato balzo, bisognerà, però, abbandonare la storia di Pete (scomparso dieci anni fa, travolto prima dai megastore Virgin e poi dalla fiumana dello streaming lo-fi), per tornare al solidissimo presente di John Surman che, prossimo a soffiare ad agosto le sue prime ottanta candeline, esce con dieci composizioni nuove di zecca per ECM: si chiama «Unspoken Words», l’ultimo nato, e l’ha registrato in quartetto con musicisti che hanno fatto della duttilità espressiva il marker distintivo del proprio idioma musicale. Rob Waring al vibrafono porta la propria esperienza eclettica tra vena compositiva, costante presenza nella New York Philarmonic e una manciata di registrazioni classiche e contemporanee. Thomas Strønen è uno dei più raffinati batteristi europei in circolazione (ha prodotto qualcosa come ottanta album in venticinque anni), mentre Rob Luft è un giovane chitarrista inglese che le principali testate mondiali specializzate di jazz hanno già «bollinato» come il nuovo Julian Lage (confermando, pure, un qualche tic nel dar battesimi a mo’ di viatico fiduciario per gli ascoltatori).
Di John Surman, andrà pur evidenziato, s’è più o meno detto e scritto di tutto in questi decenni. Con la genetica del British humour a vento, sul proprio sito web ha scritto che non aggiornerà più i contenuti, perché alla fine navigando su Internet ha imparato più cose di sé e della sua vita di quante non ne pensasse possibili. Di carattere solare e naturale propensione a guardare al futuro, l’unico modo sensato è lasciarsi raccontare direttamente da lui qualcosa di più di questo ultimo sorprendente «Words Unspoken», registrato nel dicembre del 2022, e allacciare le cinture per un viaggio dentro il tempo, tra i circuiti della storia della musica contemporanea degli ultimi cinquant’anni e qualche visione per il futuro (duro) dei giovani musicisti.

John Surman, un buon inizio d’anno questo album con dieci brani nuovi di zecca. Che bilanciamento ci si deve aspettare tra parte compositiva e improvvisativa?
È un misto di elementi diversi, in realtà. Le composizioni sono state modellate per poter essere utilizzate liberamente nell’improvvisazione; se vogliamo dirlo in termini semplici, erano messe lì per vedere se la palla girava, cercare gli spazi giusti tra di noi e trovare un linguaggio da poter condividere.
Si è avvalso di un magnifico quartetto. In che modo sperava potesse funzionare la collaborazione tra musica e musicisti?
Questa è una domanda piuttosto complicata… Torno a quello che dicevo or ora: fondamentalmente avevo bisogno di capire se le cose tra di noi potessero funzionare, ciascuno con il suo contributo, con la speranza di fare di quattro unità un intero. Non che sia una necessità imprescindibile, ma è bello quando si trova una direzione insieme per inseguire alcune idee e vedere in che territori conducano. Io mi sono limitato a dar loro alcune idee, ma mi sono ben guardato dal dirgli come metterle in pratica. Non parlo molto di questo, in generale. «Questa è la mia musica e queste sono alcune linee guida compositive, suoniamo!». I ragazzi hanno risposto alla grande, fatto che non mi ha sorpreso: li conosco molto bene, in particolare Rob Waring col quale suono da anni, con Thomas forse avevo lavorato una volta sola e Rob Luft lo avevo conosciuto da studente, ma poi lo avevo sentito suonare e ho pensato che, sì, fosse quello giusto! Siamo riusciti a creare una conversazione insieme, alla fine quello è l’obiettivo. La mia cellula elementare in generale è il duetto, che funziona molto sul dialogo. Arrivare a quattro elementi può diventare più complicato, perché si rischia di parlarsi sopra: per questo ho bisogno di persone che siano in grado di ascoltare e trovare insieme una direzione da seguire.
Una bella sfida, anche: sono musicisti con identità e storie piuttosto diverse.
Sicuramente, ma penso che tutti e tre condividano un sincero interesse ad ampio spettro per la musica in generale. Già mi era capitato in passato con Thomas, che mi ha portato alcune sue composizioni: le ho trovate davvero molto interessanti, perché completavano e definivano l’idea musicale sulla quale ero concentrato; erano molto free, aperte, contemporanee. Allo stesso tempo, l’ho sentito suonare egregiamente in contesti che potremmo chiamare più tradizionali. Per quanto riguarda Rob (Luft) è accaduto un po’ lo stesso. L’ho sentito suonare a Oslo al compleanno della mia compagna Karin Krog: era una specie di festeggiamento per la sua carriera, c’erano giovani cantanti che le offrivano un omaggio e Rob era lì ad accompagnare. Ora, ogni cantante aveva la sua identità ed erano piuttosto diverse tra di loro, dall’approccio sperimentale alle forme convenzionali: lui ha saputo prendersi cura di tutti, sapendo in modo istintivo cosa avrebbero fatto e cosa avevano in mente. Questo intendo quando di parlo di persone con un ampio spettro di interesse, gente che sa andare senza problemi in aree differenti della musica.
Tra l’altro Luft è molto giovane ma allo stesso tempo molto maturo…
Ma non sono più termini in contraddizione. Il fatto che sia giovane non esclude che abbia avuto una solida istruzione musicale. Come tutti i giovincelli in giro… Conoscono un sacco di roba! Io andavo nei negozi di dischi, oggi è tutto a portata di ascolto: se sei un musicista curioso, trovi in un attimo quello di cui hai bisogno.
In effetti, a proposito di vecchi tempi, immagino non sia stato semplice ascoltare jazz a Plymouth durante la sua adolescenza. Tutta la musica jazz e i nuovi suoni arrivavano dagli Stati Uniti.
Ah, gli inizi… La mia era una città piuttosto provinciale; il jazz si ascoltava alla radio, c’era un programma su Voice of America il lunedì che durava trenta o quarantacinque minuti. In giro non c’erano molti musicisti professionisti, a differenza di quando mi sono trasferito a Londra, direi nel 1964: lì era tutta un’altra partita e potevo trovare più o meno tutto il jazz in circolazione. Però a Plymouth c’era un tipo, si chiamava Pete Russell, e aveva un negozio di dischi che importava dagli Stati Uniti. Ci ho passato un sacco di tempo; una volta ci entro col mio sax baritono nuovo di zecca e lui mi fa: «Aspetta, devi assolutamente ascoltare il tipo che suona il baritono nell’orchestra di Duke Ellington, si chiama Harry Carney!». Ellington, da allora, ha sempre fatto parte della mia vita.
Durante l’adolescenza studiava di giorno Mozart e la classica, la sera andava in giro a suonare jazz.
Ancora prima ho iniziato cantando come boy soprano nel coro della chiesa, poi la mia voce è cambiata e ho perso quella possibilità. Allora mi sono andato a comprare un clarinetto di seconda mano per cercare di tirar fuori un po’ di musica e con il jazz sono proprio partito da lì, dal clarinetto.
La musica classica ha giocato e gioca ancora un ruolo importante nella sua visione musicale?
Molto, davvero molto. Insomma, è la musica con la quale sono cresciuto ed era quella che ascoltavano i miei genitori. A mio padre, intendiamoci, non dispiacevano musicisti come Fats Waller, ma per lo più i suoni di casa erano quelli dei concerti classici e della musica da chiesa per coro. Quello è il mio background culturale, ma aggiungo anche che la musica che ci portiamo dentro dall’infanzia all’adolescenza non se ne va più via, resta dentro di noi …
C’è stato però un qualche momento in cui si è detto: il jazz è nel mio DNA, questo è ciò che voglio fare?
In realtà non c’è nulla che assomigli a una folgorazione improvvisa. È un qualcosa che ha fatto breccia dentro di me piano piano… Ci furono due grossi concerti a Londra e a Plymouth, che vidi da ragazzino: Count Basie! Lo ascoltai e ne rimasi estasiato. Poi ho iniziato a suonare e sono stato portato dentro il Plymouth Art Center anche grazie a Mike Westbrook, col quale avevo un gruppo. A un certo punto ho capito che la matematica e la fisica non erano la scelta migliore per il mio futuro. E intorno ai sedici o diciassette anni ho sentito qualcosa che ha fatto «bang!»: il resto è storia.
Ha seguito un percorso metodico per trovare la sua propria voce nello strumento?
Mah, non saprei. È quello che ti stavo dicendo poco fa, in effetti, arriva un momento all’improvviso in cui, dopo tanto tempo che cerchi di avere il suono di Sonny Rollins o di John Coltrane, capisci che non puoi avere altro che la tua voce. Non puoi suonare come loro e allora ti dici: aspetta un attimo, forse quello che sento è il mio suono! E finisci per accettarlo e lavorarci su. Non ti accorgi di avere un suono particolare sul tuo strumento finché qualcuno non te lo fa notare.
Restando sul suono, gira un video su YouTube di un suo concerto in solo nella cattedrale di Coutances, durante l’edizione 2013 del festival Jazz sous le pommiers. L’emozione maggiore nasce anche dal saper far risuonare i timbri e gli armonici del sassofono con il contesto. Quanto è importante l’ambiente nel quale si suona?
Sì, la ricordo bene quella performance! L’ambiente fa una differenza enorme, è qualcosa di davvero importante. Forse anche per il fatto di esser cresciuto nei cori di chiesa, in quei grandi edifici la rispondenza acustica ampia mi è sempre piaciuta molto. Vedi, quando un artista sta suonando dal vivo, una buona concert hall è una sala dotata di acustica e con qualche risonanza all’interno. Il calore della musica nasce da lì e ne definisce anche la qualità, che è un altro fattore determinante. All’inizio della mia carriera ho iniziato ad avvalermi di qualche tecnico del suono, qualcuno che capisse che tipo di timbro volevo, in particolare quando ho iniziato a suonare usando l’elettronica. Anche in questo caso non sfuggo alla domanda sull’acustica, ma la ricerca è sempre la stessa. È avvilente suonare in spazi in cui percepisci che il suono va a morire, senza viaggiare; questo avviene in particolare con gli strumenti a fiato perché, alla fine, il violino ha il suo suono caratteristico che viene dalla cassa armonica, la forma eccetera; se suoni il pianoforte puoi giocartela con i pedali d’espressione per sostenere il suono; se sei un chitarrista elettrico sai benissimo che accade se usi come amplificatore un Twin Reverb. Nel caso del sassofono baritono, per esempio, la sua migliore risonanza, a mio parere, è in edifici in pietra dura, proprio come accadde in quel concerto nella cattedrale cui ti riferivi. Adoro quel tipo di risonanza acustica. Pensaci: perché ognuno di noi canta sotto la doccia? Perché il suono è buono, funziona anche a livello acustico, oltre a essere divertente.

Ha fatto riferimento all’elettronica, che credo abbia iniziato a utilizzare regolarmente quando ha lavorato per molto tempo all’Opéra di Parigi. Che rapporto ha oggigiorno con la tecnologia? È molto cambiata nel suo ruolo di produzione musicale.
Sembra quasi un luogo comune, ma oggigiorno è impossibile non utilizzarla. Ciò che offre in termini di amplificazione, costruzione del suono, modifica dei ranges di riverbero e di altri parametri di risonanza è fondamentale. Alla fine, si tratta semplicemente di un altro strumento nel gruppo. Gli stessi sintetizzatori, a pensarci, sono solo strumenti per fare musica. Poi, come tutto, puoi utilizzarli bene o male, ma lo stesso accade se suoni, che so, il trombone e trovi dei colori belli o sgradevoli. Nell’elettronica, però, resta importante che tutto non suoni con perfezione robotica, occorre sentire il fattore umano, la persona che c’è dentro la musica.
Oltre ad aver utilizzato tra i primi l’elettronica, nella sua carriera ha anche preso parte alle principali avanguardie musicali di questo o quel tempo. Quell’approccio alla musica è stato solo un fenomeno storico o è un metodo generale al quale riferirsi?
Direi che l’avanguardia cambia giorno dopo giorno, non credi? Quella di ieri è una storia di ieri e adesso c’è una nuova avanguardia. Ma ho capito il senso della tua domanda e credo che riguardi il grado di completa libertà che hai nel fare ciò che fai. Per quanto mi riguarda credo che gli anni Sessanta siano stati cruciali, quando la maggior parte di noi aveva una libertà d’espressione radicale, la più pura, avanzata, meno costruita, maggiormente aperta a soluzioni inaudite… Questa era una faccenda anche piuttosto di moda. C’erano persone che non vedevano l’ora di ascoltare cose del genere. È stato un periodo divertente, potevamo fare ciò che volevamo.
La musica astratta e di radicale libertà è anche molto «sfidante» per le persone. Quale crede debba essere il rapporto tra improvvisatore e ascoltatore?
Non posso certo chiedere a un ascoltatore di avere qualche tipo di responsabilità nei confronti della musica che gli sto suonando, posso solo invitarlo ad ascoltare, incuriosirlo, ma poi né io posso seguire ciò che credo siano i suoi gusti né lui appassionarsi necessariamente a me. Certo la fruizione contemporanea della musica non aiuta molto a essere fiduciosi… Se vedi i cartoni dei ragazzini, fino alle derive commerciali della musica, i prodotti proposti sono di livello abbastanza basso. E questo è triste perché alla fine si perde moltissimo della bellezza della musica, e quando parlo di bellezza lo dico in modo ampio, riferendomi alle emozioni: alle volte può mettere in discussione o sotto attacco la tua percezione del mondo, può farti sentire arrabbiato, farti sentire bene o a disagio. Ecco perché la ricetta migliore sarebbe sempre quella di ascoltare con apertura il maggior numero di cose in circolazione. Un fatto certamente importante è l’istruzione musicale nelle scuole fin da bambini. Per il resto la musica è cambiata moltissimo, io faccio di lavoro il musicista professionista, come se fossi un medico o un avvocato iscritto all’ordine. Così sono diventato un esponente del music business e ora faccio parte dell’industria musicale, che ti fa sentire come se tu appartenessi a una fabbrica di macchine o comunque dentro il circuito finanziario volto a fare profitto.
L’industria musicale negli ultimi vent’anni si è trasfigurata. C’è anche un problema di selezione, di come individuare talenti nel momento in cui ognuno può produrre la sua musica e distribuirla su Youtube o altri canali.
È vero, ma puoi vederla anche in un altro modo. La vita dei musicisti è stata sempre dura, diciamocelo. Non è facile emergere, ma puoi trovare il modo di tirare fuori la tua individualità. Devi percorrere alcune strade nel corso del viaggio e non tutte hanno necessariamente a che fare con la musica. La questione nella sua totalità ha a che fare con l’immagine. Pensa alla musica commerciale: è parte di quella che chiamiamo industria musicale, ma ne è solo una componente. Per fortuna, ci sono un sacco di generi diversi che si vanno creando, tipologie differenti di hip hop, rap, musica urbana o rurale e questo rende tutto più complicato nel momento in cui un musicista si affaccia al business… Ma la faccenda che riguarda i grandi talenti, forse, è diversa. Qualcuno li scoverà, li troverà, li saprà promuovere e dir loro di intraprendere una strada comune, di suonare insieme.
Facendo un piccolo passo indietro, lei ha partecipato assieme ad altri musicisti a una rivoluzione nella fruizione in Europa della musica contemporanea, non solo del jazz. È stata una risposta agli Stati Uniti, più o meno consapevole. Quale tipo di ruolo crede abbia giocato un’etichetta come ECM, con la quale lavora da decenni, nel determinare questo nuovo linguaggio?
Davvero molto, specialmente negli anni Settanta e Ottanta. Manfred Eicher è stato un personaggio fondamentale. Ha acceso i riflettori su un gruppo di musicisti europei strepitosamente creativi che suonavano in modo diverso sia dalle forme tradizionali del jazz sia da prodotti come la fusion. Lui ha dato una direzione nuova, ha trovato un anello di libertà nella quale esercitare completamente il proprio linguaggio. In quegli anni giravano personaggi come il trombonista tedesco Albert Mangelsdorff, che aveva una voce originale, e così anche altri strumentisti che facevano musica molto diversa. Manfred ha intercettato questo bisogno e non si è limitato a mettergli sotto il naso due microfoni per registrarli e farli suonare. Ha voluto che si sentisse ogni singolo particolare, a partire dalla batteria e da altri dettagli propri delle fonti sonore. Non che, intendiamoci, Blue Note con Van Gelder o Impulse! non facessero prodotti di grande qualità, ma Manfred aveva proprio un altro punto di vista nella costruzione del suono.
La copertina che con ECM ha scelto per questo «Words Unspoken» è piuttosto irrituale nell’estetica cui siamo abituati. È una foto in mare aperto di Christian Vogt, che è famoso per la sua capacità di raccontare o evocare intere storie da un singolo scatto. Crede che si addica allo spirito della musica che si trova dentro l’album?
Eh sì, mi piace per la sua capacità di essere un’immagine enigmatica. Non riesci esattamente a capire cosa stia accadendo o che storia ci sia dietro quell’attimo: questo la rende perfettamente aderente all’idea di parole non pronunciate, come dal titolo dell’album. Ascolti la musica e allo stesso modo ti chiedi: che roba è? Quale storia c’è dietro tutto ciò? Mi sembra che sia piuttosto intrigante questo legame tra immagine e musica, perché chiunque ci si accosta può tirare fuori il suo racconto personale ed è affascinante quanto fittamente le persone possano discutere di tutto questo, tirando fuori narrazioni diverse.
Certo che anche i titoli dei suoi ultimi album hanno sempre a che fare con l’idea di indefinitezza: «Words Unspoken», «Invisible Threads», «Infinite Paths», «Another Sky»…
Hai ragione, ma bisogna scappare dall’idea di essere totalmente concreti per non costringere l’immaginazione o le emozioni a prendere un corso determinato. Restare in territori ambivalenti: è questa l’enigmaticità che mi piace costruire.
Qual è lo stato di salute attuale della musica improvvisativa, jazz o come la si voglia chiamare, oggi?
Ci sono un mucchio di musicisti interessantissimi in giro in questo periodo, e c’è una grande diversità d’offerte sul piatto. C’è una forte, fortissima crescita delle musiciste donne, per esempio, e quando ho iniziato a suonare io non era neanche immaginabile. Tutt’al più c’erano cantanti, ma non tante strumentiste come oggi e questa è davvero una gran cosa. Il punto è che si torna, come sempre, all’idea di mercato e lì la faccenda si complica. Perché il problema maggiore per un giovane musicista è che in un attimo si può trovare osannato e venerato dalla critica, ma il giorno dopo esce fuori subito un altro nome che lo fa dimenticare. Sono stelle che durano pochissimo, perché il mercato ha bisogno di cose nuove. Portare avanti un’intera carriera, oggi, credo sia molto difficile. Per il resto, se mi chiedi dello stato di salute, ti rispondo senza dubbio che è eccellente.
Prima di chiudere, credo le vada rivolto un ringraziamento autentico per tutti questi decenni di musica. Ad agosto si troverà a soffiare su ottanta candeline. Com’è andato il viaggio fin qui?
È stato proprio bello e divertente. Io però non sono un tipo che si guarda indietro, non lo faccio quasi mai, non ci trovo granché di interessante. Il fatto importante è sapere che c’è sempre una prossima fermata, mentre quello che hai fatto è fatto ed è già parte del passato. A ogni modo è stato un viaggio fin qui gratificante e rifarei tutto da capo, dall’inizio alla fine. Voglio dire… Ho suonato con Gil Evans! Se ci penso è incredibile. Ho fatto tante esperienze diverse, lavorato con orchestre sinfoniche, incontrato musicisti fantastici con i quali suonare. Alle volte andando ben oltre le mie più rosee aspettative! La cosa più bella, a rifletterci su, è aver avuto l’opportunità di restare in contatto con un numero di artisti e persone straordinarie, che mi hanno dato molto. Si tratta di questo, insomma. L’unica cosa che mi pesa è l’essere continuamente in viaggio, star dietro alle mie valigie di aeroporto in aeroporto, ma alla fine ci sono sempre la musica e le persone con le quali condividi quelle esperienze.
Una volta, in effetti, ha detto che i musicisti sono gente buffa da frequentare!
Diciamo che mi ci sento particolarmente a mio agio, perché poi alla fine noi musicisti siamo personaggi, come dire, parecchio strambi! Non è fantastico?