Come era accaduto ad altre grandi voci cresciute a Chicago (vengono subito in mente Nat King Cole e Lou Rawls), Bill Henderson dovette trasferirsi a ovest per cercare di consolidare la sua fama. Hollywood tuttavia, individuando il suo potenziale di succinto caratterista, finì per monopolizzarne i talenti, e per molti anni il pubblico ha avuto più familiarità con la sua recitazione finemente essenziale e leggermente ironica, sostenuta dal calore e dalla rotondità di un baritono inconfondibile, dai margini appena nasali, che con il suo modo del tutto originale di trattare e illuminare una canzone. Dagli anni Settanta (quando è stato frequente presenza televisiva, specie in sitcom nere come The Bill Cosby Show, Sanford & Son, The Jeffersons e Good Times) e in particolare negli Ottanta e Novanta, Henderson ha recitato con disinvoltura e naturalezza in parti non cantanti per film di notevole risonanza come il brutale Murphy’s Law di J. Lee Thompson, nei panni di un poliziotto in pensione (e amico del protagonista Charles Bronson) vittima della vendetta di un killer psicotico, o la comica avventura western per yuppies newyorkesi, City Slickers di Ron Underwood, a fianco dell’emergente Billy Crystal e del veterano Jack Palance. Solo nella parodistica commedia rock’n’roll del 1983, Get Crazy, che lo vide, nel ruolo di «King Blues», scatenare il suo spirito satirico nell’affrontare il lato più ruspante dei blues di Chicago (bizzarra e memorabile è la scena del funerale in cui alterna The Sky Is Crying a un improvvisato, oltraggioso sermone), e in White Men Can’t Jump di Ron Shelton, del 1992, in cui si affianca a Jon Hendricks e Sonny Craver nel formidabile trio vocale dei «Venice Beach Boys» per creare (con la chitarra di Phil Upchurch) la più animata e swingante versione di Just A Closer Walk With Thee, Bill trovò spazio per mettere in luce il cantante insieme all’attore.

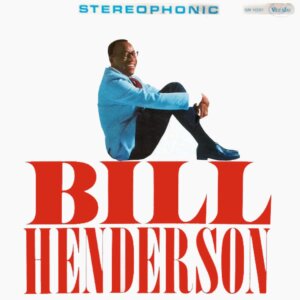
I due ruoli non dovevano essere visti separatamente, secondo lui. «Fondamentalmente sono un cantante», mi disse a metà degli anni Ottanta il cordiale e occhialuto Bill tra un set e l’altro, al Milestones, un elegante jazz club di San Francisco dove si esibiva durante una pausa delle riprese di un film (proprio Murphy’s Law). «E a Hollywood mi avvicino ancora alla recitazione come cantante, un cantante che ascolta prima i testi: perché per me le battute della sceneggiatura sono come le parole di una canzone. A volte hai dei bei testi, a volte ne hai di mediocri, e devi fare del tuo meglio per renderli comunque credibili o interessanti. L’unica vera differenza è che come attore non puoi tirarti indietro: devi recitare, qualunque cosa accada, perché per diventare un attore affermato e realizzare il tuo potenziale sei costretto a adeguarti alle più diverse situazioni. Come cantante, invece, non è proprio necessario che tu canti quello che non hai voglia di cantare. A meno che, ovviamente, motivi commerciali non ti spingano a farlo.» Un artista vocale che nei molti decenni della sua carriera non ha mai avuto una mentalità commerciale e che ha rifiutato importanti contratti discografici per non essere costretto ad affrontare materiale scadente o inadatto, il Bill Henderson che si vedeva sul palco di un’intima jazz room, sostenuto – idealmente – da un trio guidato dal pianoforte (al Milestones c’era l’ottimo Gerald Wiggins, il «Teddy Wilson dell’Ovest»), era un cantante che viveva un rapporto totalmente simbiotico con il suo repertorio, assaporando i testi e le melodie di ogni canzone standard e di ogni occasionale blues che sceglieva di interpretare – e ovviamente godendo della libertà e del relax che il contesto gli permetteva. Il suo naturale senso dell’understatement e il suo gusto raffinato e ben consolidato, però, lo tenevano sempre vigile: sapeva dare a una canzone un tocco profondo e personale con eleganza e semplicità, facendola sua senza strafare. Un baritono fluido e morbido, pervaso da un feeling oscillante tra lirismo e ironia, con risonanze ricche e bronzee e accenti di un crooning asciutto e palpabile, Henderson era un maestro quando si trattava di definire gli elementi essenziali di una melodia, di tracciarne i contorni e scoprirne il vero nucleo espressivo. Dall’agrodolce Tulip Or Turnip di Duke Ellington all’arioso e suadente A Sleepin’ Bee Harold Arlen (nobilmente letterario: il testo, com’è noto, era nientemeno che di Truman Capote), dalla pensosa tenerezza di I See Your Face Before Me di Dietz e Schwartz allo shouting controllato e pungente del classico Roll ‘Em Pete di Big Joe Turner (filtrato attraverso Joe Williams), raccontava storie con una forte sostanza musicale oltre che lirica: mentre le sue frasi peculiarmente staccate e ritmicamente flessibili, insieme caute e dalla swingante muscolarità, contrassegnate da brevi vibrati e punteggiate da accenti colloquiali e pause eloquenti, molto spesso imprevedibili, portavano un inconfondibile e contagioso melange di abbandono romantico e concretezza blues, streetwise – con una sfumatura umoristica che rendeva la sua esibizione e la sua presenza (gli piaceva anche scherzare attorno a una canzone, con il controllato piglio del comedian, scambiando piccole battute con il pubblico) calda ed esilarante.

Una creatura del South Side di Chicago, dove diceva di essere nato nel marzo 1930 (in realtà 1926, come rivelerà in seguito), e fratello maggiore di Finis Henderson, illustre ballerino jazz, William Randall Henderson condivideva con i concittadini Cole, Rawls, Johnny Hartman, Joe Williams, Dinah Washington una rotondità di enunciazione non retorica, un’attrazione per l’affermazione lirica formosa e ben scolpita – e un’assoluta grazia ed elasticità ritmica. A Joe Williams, in particolare, lui guardava con affetto, percependo un’affinità nel linguaggio. «Crescendo», ricordava, «ho ascoltato tutti i tipi di cantanti: Sinatra, Dick Haymes, Arthur Prysock. Ma Joe è stato colui che – essendo stato sulla scena di Chicago per così tanti anni, prima di trovare la celebrità con Count Basie – ha avuto davvero un’influenza su di me, almeno per quanto riguarda l’ispirazione generale e una certa amichevole guida. Non direi che canto come lui, ma molte persone pensano che la forza espressiva e la potenza che esercito mentre mi esibisco siano una faccenda un po’ alla Joe Williams: e questo non può che rendermi orgoglioso. Copriamo lo stesso territorio, dal blues al jazz. Ed è così che funziona nel mondo della musica, una questione di territorio. A volte lo conquisti e a volte no: ma Dio ti dà la possibilità di tornare indietro e riprovare, finché non risolvi ogni cosa!» Con un background nel canto che risaliva alla sua prima infanzia (aveva quattro anni quando il comico e fisarmonicista Phil Baker lo scelse per eseguire una routine di canto e ballo nel suo spettacolo) e proseguiva con le riviste amatoriali delle scuole superiori, il tempo trascorso nei servizi speciali dell’esercito per intrattenere le truppe in America e in Europa, e gli anni difficili nei jazz club di Chicago, il primo territorio musicale che Bill Henderson conquistò davvero fu quello dell’hard bop. Convinto dal pianista Billy Taylor a trasferirsi a New York, dopo una strana parentesi come spazzacamino e poi come raccoglitore di gamberi al Gaslight Club (un lavoro bislacco e divertente, diceva, creato per tenerlo occupato) Henderson colpì Horace Silver, il maestro dell’hard bop, come interprete vocale ideale per la sua composizione funky-latina Senor Blues, un successo nella comunità jazz. In quell’ormai classica registrazione Blue Note realizzata nel giugno 1958, il virile e già maturo baritono di Bill si abbinava dinamicamente al pianoforte intriso di gospel di Silver e alla densa energia del suo quintetto, esprimendo l’atmosfera blues e mutevole dei testi in una singolare combinazione di arguta moderazione e vigore declamatorio. Durante i mesi successivi, mentre mostrava la sua abilità con le parole anche come presentatore all’Apollo Theatre di Harlem e come dj radiofonico, il cantante apparve in televisione con Buck Clayton, Roy Eldridge, Stuff Smith e altri giganti in una puntata dell’Art Ford’s Jazz Party e su disco con altri jazzisti di primo piano: un quintetto all-stars (Charlie Rouse, Julius Watkins, Hank Jones, Wilbur Ware e Philly Joe Jones) in un asciutto e incisivo blues dal puro respiro bop, Busy Signal, pubblicato su un 45 giri Riverside, e il trio del mago dello Hammond, Jimmy Smith, in alcune ballad (Willow Weep For Me) e blues (Ain’t That Love di Ray Charles) per l’etichetta Blue Note. Considerando queste e le successive collaborazioni (nel 1961 Bill si unì ai Jazz Messengers di Art Blakey per una tournée in estremo oriente) e forte di una compatibilità armonica, ritmica ed emotiva con il genere, il critico Will Friedwald – nel suo libro Jazz Singing – lo ha descritto come il cantante hard bop per eccellenza. Henderson, tuttavia, rivelò presto di essere più di questo.

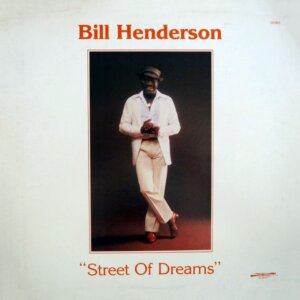
Il primo p a suo nome, registrato per la Vee Jay di Chicago nell’ottobre 1959 e intitolato semplicemente «Bill Henderson Sings» (quello di maggior successo, due session con il trio del concittadino Ramsey Lewis, che aveva condiviso gli inizi della sua carriera, e un sestetto eccezionale arrangiato da Benny Golson, con Booker Little e la sezione ritmica di Miles Davis), e il secondo, «Bill Henderson» (realizzato tra il dicembre 1960 e l’aprile 1961, con l’orchestra di Jimmy Jones, varie formazioni guidate da Thad Jones o Tommy Flanagan e un trio del giovane pianista bostoniano Eddie Higgins, allora in forza alla Vee Jay), dimostrarono che insieme a un chiaro ed eloquente contorno stilistico, nella profondità e dinamicità del sound e nel mobile e colloquiale controllo del fraseggio, si accompagnava una personalità complessa e versatile. Sia in standard come The More I See You e I Can’t Give You Anything But Love e vari gioielli di Rodgers e Hart (It Never Entered My Mind, Bewitched, My Funny Valentine), sia in ballad contemporanee come Never Will I Marry e Joey, Joey, Joey di Frank Loesser, la seconda magistralmente recitata in un largo e musicalissimo rubato dai penetranti crescendo, come My, How Time Goes By di Cy Coleman, e un suggestivo e teneramente poetico Twelfth Of Never (le sue palpabili pennellate di vibrato a decorare con matura grazia l’immaginifico lirismo del paroliere P.F. Webster), Bill emerse come un sensibile e dinamico balladeur dall’asciutto, talora insofferente romanticismo bluesy, sofisticato quanto scevro di sentimentalismi, con un senso della melodia secco e sottilmente stravagante, spesso sorprendente, sostenuto dal timing incisivo di un ballerino di tip tap, timing che s’imponeva ovviamente anche nella magistrale articolazione (con icasticità, humor e swing) di puri temi hard bop come Moanin’ e Sleepy e del nostalgico quadretto firmato Nat Adderley e Curtis Lewis (e delicatamente incorniciato dagli archi di Jimmy Jones), The Old Country, che Bill percorre come un sax tenore dotato di parola. In un terzo disco tratto dalle stesse sedute del secondo, e pubblicato soltanto un decennio dopo, mirabile era la versione della blue ballad che gli dava il titolo, Please Send Me Someone To Love di Percy Mayfield, che Bill e Eddie Harris – sorretti da soli chitarra e contrabbasso – facevano a gara a chi la distillava con la più sommessa e delicata, seppur tangibile, bluesiness: e non meno incantevoli, in un ben distinto cambio di atmosfera, si rivelavano la più sorridente e contagiosa richiesta di matrimonio in chiave jazzistica, Love Is A Bug (con un esemplare quartetto Tommy Flanagan-Freddie Green-Milt Hinton-Elvin Jones), che sarebbe rimasto a lungo un pezzo forte del cantante, e una rilassata e tuttavia elettrizzante rilettura del classico Yes Indeed, con l’orchestra chicagoana di Riley Hampton.

Poi, nel cuore degli anni Sessanta, un album solido e intimo semplicemente intitolato «With The Oscar Peterson Trio» (Oscar con Ray Brown e Ed Thigpen: perfetta combinazione per una schietta aventura in swing con Bill), e una raccolta eclettica, sui margini eccentrici del jazz, con pieno supporto orchestrale curato da Jimmy Jones, Rene Hall e Bobby Scott, «When My Dreamboat Comes Home» (entrambi per MGM/Verve: 1963 e 1965), gli permisero di muoversi liberamente attraverso molteplici stati d’animo e diverse regioni della forma-canzone, arrivando ad alternare, nel primo disco, il blues tradizionale (Baby Mine) e Charles Trenet (I Wish You Love) e toccando felicemente persino Bob Dylan, nel secondo (Lay Down Your Weary Tune). Gershwin (I’ve Got A Crush On You), Porter (At Long Last Love), Kern (The Folks Who Live On The Hill), Jule Styne (un magnetico, sorprendente People), Steve Allen e Ray Brown (un eccezionale Gravy Waltz, eccentricamente e sapidamente dialogato con Ray e Oscar), trovarono in lui un interprete attento e solare, dall’approccio originale e più o meno sottilmente creativo, con quel fraseggiare – come notò Leonard Feather – che portava l’unicità della sua firma, certe parole spaziate «come se le sillabe fossero separate da una virgola o persino da un punto e virgola», mantenendo però una perfetta costruzione sintattica. Più avanti, in quel decennio, Bill sperimentò la disciplina della vita on the road – sia nei tour americani che in quelli europei – con la sempre potente Count Basie Big Band, interpretando un ruolo che un decennio prima aveva fatto guadagnare a Joe Williams il suo prestigio internazionale. I tempi erano cambiati, nel gusto musicale, e lui non fu in grado di ripetere i trionfali risultati di Joe. A ogni modo, la sua unica registrazione commerciale con Basie – una versione toccante e colloquiale del Yesterday di Lennon e McCartney, su un arrangiamento in chiaroscuro di Chico O’Farrill – ma anche quelle dal vivo apparse successivamente su etichetta Monad (un discorsivo If I Could Be With You, un esplosivo Broadway, e quel You Are My Sunshine già felicemente sperimentato con Peterson) testimoniavano la sua versatilità, il suo controllo e il suo feeling come ideale cantante di una moderna orchestra swing.


Fu dopo aver lasciato il Conte, nel 1968, che Henderson decise di stabilirsi a Los Angeles, dove lavorò come promotore discografico per Bill Cosby, un buon amico, allora in piena fase ascendente, e iniziò ad apparire in televisione e nei film: il primo tra questi fu il thriller nero Trouble Man, del 1972, commentato dall’ipnotico score funky di Marvin Gaye, che rimarrà anche una delle sue parti di maggior rilievo, profondamente umana e dialogata con calda tensione soulful: quella dello zoppo Jimmy, gestore della sala da biliardo dove regna il protagonista e suo protettore, l’invulnerabile Mr. T interpretato da Robert Hooks. Pur deluso dalla scarsa attenzione dell’industria discografica e del pubblico giovane per le solide e autentiche voci jazz, mantenne comunque una sua presenza sulla scena jazzistica: e verso la metà degli anni Settanta riuscì a trovare in Albert Marx della Discovery Records un produttore più interessato a servire il suo stile e il suo impegno per l’eccellenza musicale che a produrre effimeri successi. Con piccoli gruppi di pianisti West Coast come Joyce Collins e Dave McKay, che lo integravano con puntualità e sensibilità, Bill Henderson, nei suoi album Discovery, seppe dare performance che sono eleganti in modo conciso, ritmicamente vitalissime e pensosamente mature. «Live At The Times», una esemplare registrazione in club del 1975, e «Street Of Dreams» e «A Tribute To Johnny Mercer», due nominations ai Grammy del 1979 e del 1981, illustrano pienamente le qualità del suo baritono rilassato e mobile, i fluidi ritardi e le cesure nella sua sintassi ritmica, le pieghe blue e gli espressivi, morbidi riflessi nasali, le fini sfumature e la forza grafica della sua dizione, che ringiovanisce standard come All The Things You Are o Angel Eyes (un ingegnoso e insolito duetto con miss Collins, che sulla stessa struttura armonica canta il testo di This Masquerade in uno scattante interplay melodico) e classici hard bop come Whisper Not di Benny Golson e infonde anche canzoni pop post-Beatles (Sorry Seems To Be The Hardest Word di Elton John o Your Smiling Face di James Taylor) con un’eloquenza jazz senza tempo, che anni prima (1971) aveva già fatto vibrare le due facciate di un 45 giri Warner arrangiato da Mike Melvoin, tra il pulsante Marley Purt Drive dei Bee Gees (una «Sunday drive» per big band) e il malinconico Living Without You di Randy Newman, dal colore country-pop.

Anche se un po’ discontinuo negli arrangiamenti e nella stessa esecuzione, l’omaggio a Johnny Mercer – in particolare – offriva alcuni degli episodi più intriganti del jazz vocale dell’epoca: episodi (tra cui un trascinante On The Atchison, Topeka And Santa Fe e un lento, irresistibile Hooray For Hollywood, l’omaggio giocoso di Bill e Johnny a Movieland) che rivelano una visione poetica condivisa dal grande interprete di Chicago e dal maestro paroliere di Savannah, con un umorismo gentile ma tagliente e quella predilezione tangibile per i colori musicali e il potere evocativo delle parole, già del resto evidente nella perfetta lettura Vee Jay del gioioso sermone merceriano, Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive, e sintetizzano ancora, vividamente, le doti di Bill Henderson come cantante e attore. Il cantante trovò un suo rilievo crepuscolare. In «The Art Of The Song» del Quartet West di Charlie Haden (Verve 1999), sorta di incantatoria raccolta di short stories in jazz cui partecipano l’arrangiatore-pianista Alan Broadbent e un’altra illustra veterana, Shirley Horn, l’ultrasettantenne baritono chicagoano riemerse in grande stile, dando agli episodi di cui era protagonista un colore emotivo denso quanto elegante. Enunciatore personalissimo, dal taglio staccato e assorto, Bill è insieme attore, balladeur e jazzman quando affronta le due melodie di Haden su cui Arthur Hamilton, noto un tempo per Cry Me A River, ha cucito testi di raffinata arguzia (Ruth’s Waltz, subito ripreso nelle «Capitol Sessions» di Haden con Mike Melvoin) e di struggente devozione (Easy On The Heart). La qualità malinconica di uno strumento vocale sempre espressivo benché invecchiato (una malinconia comunque obliqua, la sua, con barbagli di humor) si accentua in You My Love di Jimmy Van Heusen, prosciugato in uno scarno bassorilievo melodico sul mobile orizzonte orchestrale: e in un bellissimo Why Did I Choose You. Qui ciascuna parola acquista peso e riverbero nell’equilibrio del racconto, alla cui pienezza e limpidezza lirica Charlie Haden replica con un assolo che ha l’asciutta, aggraziata dignità di un monologo drammatico per contrabbasso. Ancora eloquente, a nuovo secolo inoltrato, appariva lo Henderson ottantenne, grande vecchio (allora, purtroppo, non sufficientemente celebrato) della vocalità jazz: ospite di Chico Hamilton in Don’t Be That Way e Ain’t She Sweet e tornato leader in «Live At The John F. Kennedy Center For The Performing Arts» (su etichetta WebOnly, 2004, con due omaggi merceriani, I Thought About You e Old Black Magic, e un suggestivo programma strayhorn-ellingtoniano culminante in un A Flower Is A Lovesome Thing che confermava il sobrio romanticismo dell’interprete) e «Beautiful Memory» (su Ahuh, sempre live e in trio, tenendo ancora desto il repertorio Discovery). «Beautiful Memory» era del 2007: l’anno precedente Bill aveva fatto l’ultimo dei suoi tanti cameo cinematografici, nella fugace parte di un pawnbroker in Lies And Alibis, labirintica commedia gialla di identità intrecciate, con Steve Coogan e Sam Elliott. È morto a novant’anni appena compiuti, il 3 aprile del 2016, a Los Angeles, a pochi giorni di distanza da altri due grandi individualisti vocali legati alla West Coast, Merle Haggard e Ernestine Anderson, del repertorio della quale, nel live del 2004, aveva ripreso – con sempre impareggiabili timing e arguzia – l’accattivante blues «sulla strada», Never Make Your Move Too Soon.
